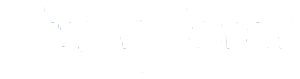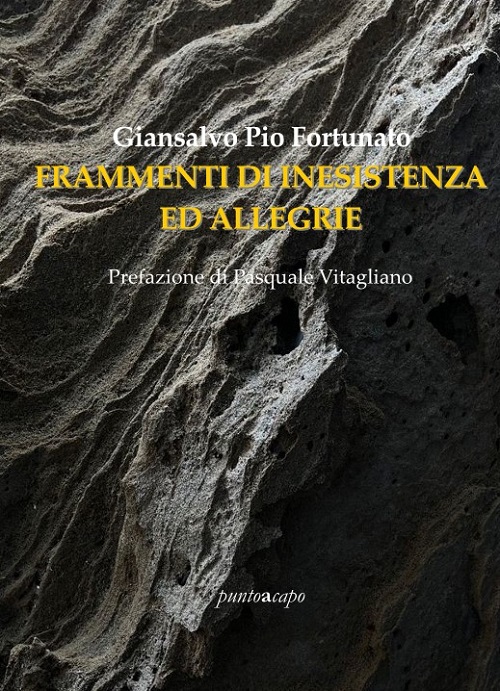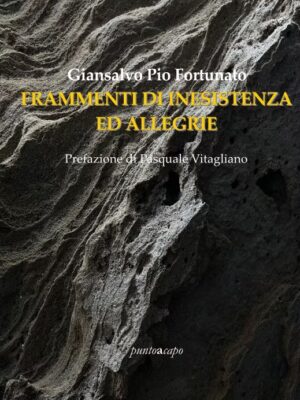 Quest’ultimo libro di poesia di Giansalvo Pio Fortunato, non proprio un libretto (circa 100 pagine piene, se si escludono prefazione, indici e pagine bianche tra le sezioni), viene donato a tutti con generosità e merita ogni attenzione del lettore per via del messaggio che si propone.
Quest’ultimo libro di poesia di Giansalvo Pio Fortunato, non proprio un libretto (circa 100 pagine piene, se si escludono prefazione, indici e pagine bianche tra le sezioni), viene donato a tutti con generosità e merita ogni attenzione del lettore per via del messaggio che si propone.
Appunto perché intendere il messaggio dipenda sempre da interpretazione, come per la buona poesia, qui la necessaria perspicacia può sempre mancare il bersaglio.
In genere ci si trova di fronte a qualcosa di complesso, e credo sia per una scelta precisa dell’autore: se l’argomento “di cui” far poesia non è agevole o facile, si poteva usare un linguaggio, una forma piana, che arrivasse immediatamente al lettore? Si poteva, ma in questo caso s’è voluto adottare una forma adatta al tema: un tema di cui non è agevole dire. Ritengo dunque che si tratti di una vera e propria scelta di poetica che, come un “sussulto drammatico”, “scardina … il verso/prima dello squasso”. Dunque il linguaggio usato, che, salvo eccezioni, non risulta un linguaggio piano, facile a porgere i significati voluti. A volte s’illimpidisce il senso; si sprigiona il ritmo della reiterazione, come “non so” reiterato a capo di ogni stanza del componimento, fino quasi alla fine.
Ciò non vuol dire che si tratti di un linguaggio del tutto criptico. Il lettore può trarre le proprie suggestioni dai versi in due modi, usati insieme: uno è la sorveglianza di parole-chiave che ricorrono, il secondo consiste nell’interpretare in base a spiragli d’evidenza che talvolta il verso s’apre.
Come ipotizzato, complesso e controcorrente è l’argomento che il libro avanza. Parliamo del titolo: Frammenti d’inesistenza implica un termine, inesistenza, in cui riecheggia la poesia del Novecento. Per dirne uno, il Biglietto lasciato prima di non andar via di Giorgio Caproni:
“Se non dovessi tornare,
sappiate che non sono mai
partito.
Il mio viaggiare
è stato tutto un restare
qua, dove non fui mai.”
Ma nel nostro caso non si tratta dell’epitaffio d’una vita, è autore giovanissimo sebbene non agli esordi.
E perché frammenti? Anche se il prefatore auspica, ritiene, che sia quella del poeta “situazione dalla quale togliersi” il messaggio potrebbe essere: più di sempre, nel momento storico che ci tocca, l’essenza dell’esistenza è l’in-esistenza o un esistere a frammenti e a sprazzi: è l’inesistenza e il non l’esistere il soggetto, perché questa che viviamo non può definirsi vita ed esistenza.Se così fosse, allora perché congiungere la prima parte del titolo, tramite e, ad allegrie, così completando il titolo stesso? E quali allegrie? Se è come ipotizzo, allegrie andrebbe letto nel modo dell’ironia: si direbbe che con questo tipo di esistere inesistente vi sia poco da stare allegri.
A me il libro sembra un documento del disagio, in cui anche la prima parte e tutte le menzioni e gli svolgimenti della mitologia classica o di luoghi biblici vengono usati per una operazione d’autenticità e d’esistenza (ovvero esistenza sofferta).
Si torna così ai due modi che ho proposto per leggere questa poesia. V’è una parola che compare sùbito, tanto per non attendere troppo, e poi torna un numero notevolissimo, che non preciso, di volte: si tratta di “furia”. Come va intesa? “fretta? Non di necessità ma qualcosa di simile. Vedo dapprima riferita al passato: “furia del già fatto”. Il già fatto va inteso come “rovina”: così L’arte del verso/è già malamente tranciata – gridò Orfeo/innanzi all’inesorabile” (i corsivi sono sempre nel testo). Ma è anche dell’avvenire: “verrà la furia” e, connessa, la “mia confessione sul peso del mondo”. E “furia” è il presente “nella furia/che ancora afferma:/ Tenete i centri alla sete/ogni sete è la nuova bevuta: /amatela”. Non è rovina tutto il tempo, dunque?
I nomi delle immagini nei titoli sembra servano qui a rendere l’evidenza che l’autore intende proporre. La prima parte si chiude con il titolo “Schi zo frenia” (staccato) per indicare anche visivamente qualcosa: e la seconda s’intitola “Mogano”, recante in epigrafe “è un miracolo/l’udire il cuore”. Le dieci composizioni di tale parte, che forse ci invita di più alla possibilità d’intendere, sono tutte titolate al Mogano (sempre maiuscolo), questo legno che ha fama di durissimo e pregiato. Prende campo un “noi”, sùbito nel secondo verso, “È la parola spezzata/che ci lega nei clamori della distanza”.
Quel “ci”, allora, come si può intendere? E poi “in coppia”? e “due cuori”? e così via. Il lettore avanza le sue congetture, ma l’autore certo firmerebbe che “Giuda non m’appartiene” (in linea con la durezza della lealtà) sebbene leggere “l’amore solo mio” possa escludere qualunque altro, anche l’Altro: l’amore è difatti “non ricambiato, apocalittico” e “Mogano” dev’essere la durezza che si addice a qualcuno o a una situazione o alla stessa divinità silente – “resisti”… eppure, infine “amando Mogano, si ama la furia; amando Mogano,/amo l’altro me.” E l’altro non potrà anche intendersi come “altro me”? Forse sì e si può anche amarla, la furia, come si può amare il negativo: non viene qualcosa di simile nelle Confessioni di Agostino? Oltre questo punto la congettura non può andare, è già arrischiata.
Di gran limpidezza paiono i versi che quasi chiudono la parte: ad esempio, del X componimento,
“ora non sosta la sera:
è quasi un’eternità di luci in cerchio
che sovrasta la tenebra,
ed il saluto del giorno ti scuote
al ramo lancinante della parola.
Il verso troverà altre case
Io no.”
Ipotizzo che “furia” possa essere anche l’opposto, nella simbolica mentale dell’autore, del “distacco” (come atteggiamento della mente):
“La furia sa costruirsi
nel legame di un abbandono:
ad ogni distacco
si resiste col tempo di una goccia…”
Ma l’andirivieni è la (o “una”) sostanza della vita? “… Il passaggio è questo andirivieni…”
E “siamo unico Mogano”, con cui chiude questa parte, sembra essere al prezzo del “mio sacrificio silenzioso” o altrove, “La mia è una storia d’inappetenze”. Il lettore si può porre molte domande; ma non v’è risposta se non in quanto d’enigma in versi. Per poi riprendere la difficoltà dell’ordito in “Adamo era solo”, e, quando ci si rivolge al femminile “amica mia” – altro punto che pare limpido, leggiamo
“un tramonto continuo
sa insegnare la sopravvivenza
Angoscia – tu la definisci –
Io la scrivo: esercizio all’esistenza…”
Ma, di nuovo, tramonto continuo è la vita? Un modo greco, un po’ più drammatico. E di quale predatore è preda, la preda che “è il mondo” che “ama la rovina”? Ci si avvicina, comunque, a una intenzione.
Sembra che risulti una visione religiosa ma tormentata delle cose. Subentra l’immagine di Gerico, che nella pagina del Libro cade al suono delle trombe; comunque “tutto è libero”. Toccante, forse ancora proiettiva in parte, la versione data di Ifigenia e della sua storia.
Preciso ancora che non si tratta d’una visione, problematica certamente ma in certo modo risolta, come quella delle Confessioni, il capolavoro della letteratura cristiana dei primi secoli. C’è una certa distanza e adesso non parlo affatto del linguaggio. Dico che qui, almeno in parte (ci sono momenti in apparenza chiari, come ho cercato di mostrare), si ritrova anche una lettura della storia e del Dio-misura, un drammatico occhio che sorveglia ma non interviene se non nelle cose stesse. Questo Dio, come esattamente si cita nella prefazione, “ama la rovina”. Valga l’auspicio che l’autore trovi o abbia visto davvero “con la poesia un luogo finale di pace e armonia” (prefazione) pur in “voce da solitudine”, la strada:
“Signore, esaudisci la mia voce –
per cogliere il deserto…
la storia…
dell’acqua che sgorga dalla fessura
a creare sorgente e dono.
Signore, sono all’alba e al tramonto:
mi muovo.”